20 Luglio 2023
The Laboratory of the Future
La 18a Biennale di Architettura di Venezia
ha aperto ufficialmente il 20 maggio, dopo la
vernice del 18 e 19, per rimanere visibile al
pubblico fino al 26 novembre 2023.
La mostra è curata dall’architetta, docente e
scrittrice Lesley Lokko, forse universalmente più
nota per la produzione letteraria di successo che
per le esperienze professionali e didattiche.
The Laboratory of the Future ruota interamente
attorno a due temi cardine, decolonizzazione e
decarbonizzazione, in una sorta di connubio di
intenti tra curatrice e Fondazione Biennale:
Lokko ha coordinato i lavori in sintonia con un più
esteso indirizzo che vede la Biennale impegnata
nel contrasto al cambiamento climatico
attraverso la promozione attiva di un modello più
sostenibile per la progettazione, l’allestimento e
lo svolgimento di tutte le sue attività.
L’obiettivo condiviso è quello di azzerare
l’impatto carbonico dell’evento, pianificandolo in
base a principi di sostenibilità ambientale. Le
principali azioni messe in campo, che implicano
la complicità di organizzatori, partecipanti e
pubblico, sono l’utilizzo di energia da fonti
rinnovabili; la riduzione e il riciclo di materiali,
attrezzature e allestimenti; un’azione diffusa di
sensibilizzazione dei visitatori, chiamati a
valutare le proprie modalità di spostamento e di
visita, in un contesto – la laguna di Venezia – in
cui la mobilità è tra le componenti più impattanti
in termini di impronta ambientale.
I temi su cui i partecipanti sono stati chiamati a
esprimersi sono dunque quelli su cui
l’organizzazione stessa riflette, in maniera
allargata e pubblica (decarbonizzazione), e quelli
che presumibilmente hanno interessato le
vicende private e personali della curatrice,
cittadina scozzese e ghanese, naturale
“prodotto” della diaspora africana
(decolonizzazione).
L’esposizione raduna 89 partecipazioni, di
cui oltre la metà provengono dal continente
africano o discendono dall’enorme dispersione
che la storia ha messo in atto sulla sua
popolazione. L’età media è di 43 anni e per la
prima volta in assoluto quasi la metà degli
architetti selezionati lavora in studi a conduzione
individuale o composti da un massimo di 5
professionisti. Pressoché assenti, seguendo la
tendenza delle scorse edizioni, le grandi “firme”
della produzione architettonica internazionale.


Installazione nel salone d’ingresso del Padiglione Centrale ai Giardini. Appesa al soffitto la “mappa” tridimensionale che contiene frammenti di tutte le partecipazioni a The Laboratory of the Future
Intraprendendo la visita dal Padiglione Centrale
dei Giardini, spazio-manifesto di ogni Biennale, ci
si trova al cospetto di una moltitudine di sottili oggetti rossi che occupano a mezz’aria il cuore
del grande salone d’ingresso. L’installazione
raggruppa sagome che replicano in forma
iconica ciascuno dei contributi di Laboratory of
the Future, disseminati tra le varie sedi della
mostra e qui idealmente riuniti in un corpo
collettivo. La presenza simultanea delle voci di
tutti gli invitati in questa sorta di mappa
collegiale dà il benvenuto ai visitatori ed è un
invito a «stabilire connessioni tra le
partecipazioni, le idee, le forme, proprio come la
mostra spera di fare nel suo complesso». Nelle stanze perimetrali del padiglione, la
sezione Force Majeure riunisce il lavoro di 16
studi che, come in una questione di Forza
Maggiore «che in alcune giurisdizioni può essere
addotta a prova se l’evento in oggetto è
imprevedibile, esterno e irresistibile, offrono un
esempio della potenza creativa della cultura
Black Atlantic, le cui radici affondano in un
passato millenario e si protraggono verso il
futuro».
In questo segmento Adjaye Associates – con un
intervento che in quanto a modalità espressive
sarebbe ormai il caso di definire tradizionale, nel
contesto della Biennale – presenta una serie di
poetiche architetture attraverso modelli in scala
che restano tra i rarissimi edifici esposti.
Lo studio Adjaye, cofondatore insieme a Lesley
Lokko dell’African Futures Institute, è presente
anche negli spazi esterni dell’Arsenale con una
struttura interamente in legno chiamata Kwae
(“foresta” in una delle principali lingue del
Ghana). La costruzione propone una pausa lungo
il percorso espositivo, uno spazio dedicato alla
meditazione ma anche a piccoli eventi,
presentazioni, lezioni. La forma è quella di un
prisma piramidale punteggiato da una grande
apertura di ingresso e due oculi che inquadrano
il cielo; lo spazio interno è scolpito attraverso un
ricercato schema di posa dei listoni che lo
conformano e delimitano, a ricordare la
spazialità ancestrale di una caverna.








Adiave Associates, Adjaye Futures Lab, modelli. Sezione Force Majeure, Padiglione Centrale Giardini. Kwae. Vista d’insieme e vista dell’interno con la particolare soluzione costruttiva dell’involucro del padiglione realizzato all’Arsenale
Tornando alla sezione Force Majeure, Kéré
Architecture, dopo aver ricordato che l’intero
continente africano produce meno del 4% delle
emissioni mondiali di gas serra,
attraverso Counteract, installazione tripartita in
ordini temporali, celebra la qualità della
tradizione architettonica dell’Africa occidentale,
fa il punto sulla situazione odierna e propone un
approccio per il futuro. L’appello di Kéré ad
adottare soluzioni che sappiano replicare i valori
del passato non si esplicita nell’autoreferenziale
narrazione della sua feconda produzione, ma
esamina da vicino materiali, tecnologie
costruttive, scenari. Attraverso una riproduzione
fotografica, icona dello status quo, e
l’ambientazione in scala 1-1 di un ipotetico
spazio abitabile capace di rimettere al centro i
saperi del passato, propone una valida
“contro-azione” nel modo diffuso di fare
architettura, ampiamente avvalorata dalle sue
numerose opere realizzate, anche se del tutto
escluse dalle scelte espositive.
Ancora incentrato sulle relazioni tra passato e futuro, è il lavoro di Atelier Masomi. Certamente
meno nota rispetto agli autori precedenti,
Mariam Issoufou Kamara si concentra su un
luogo specifico: la città di Niamey, in Niger, con
le sue caratteristiche ecologiche, economiche,
culturali e tra esse l’eliminazione delle tecniche
costruttive tradizionali dalla coscienza pubblica,
rappresenta un laboratorio dove realizzare
un’architettura ispirata al passato ma proiettata
verso l’innovazione e le esigenze del futuro.
Process attribuisce grande importanza all’eredità
culturale, alle narrazioni, all’ingegnosità e
all’identità del contesto, proponendone la
rilettura e la rielaborazione in chiave
contemporanea attraverso modelli, video e
disegni. Scegliendo di tracciare le piante sui muri
della sala espositiva, Kamara vuole richiamare
l’attenzione, come lei stessa afferma,
«sull’importanza di camminare con leggerezza
su questa terra».


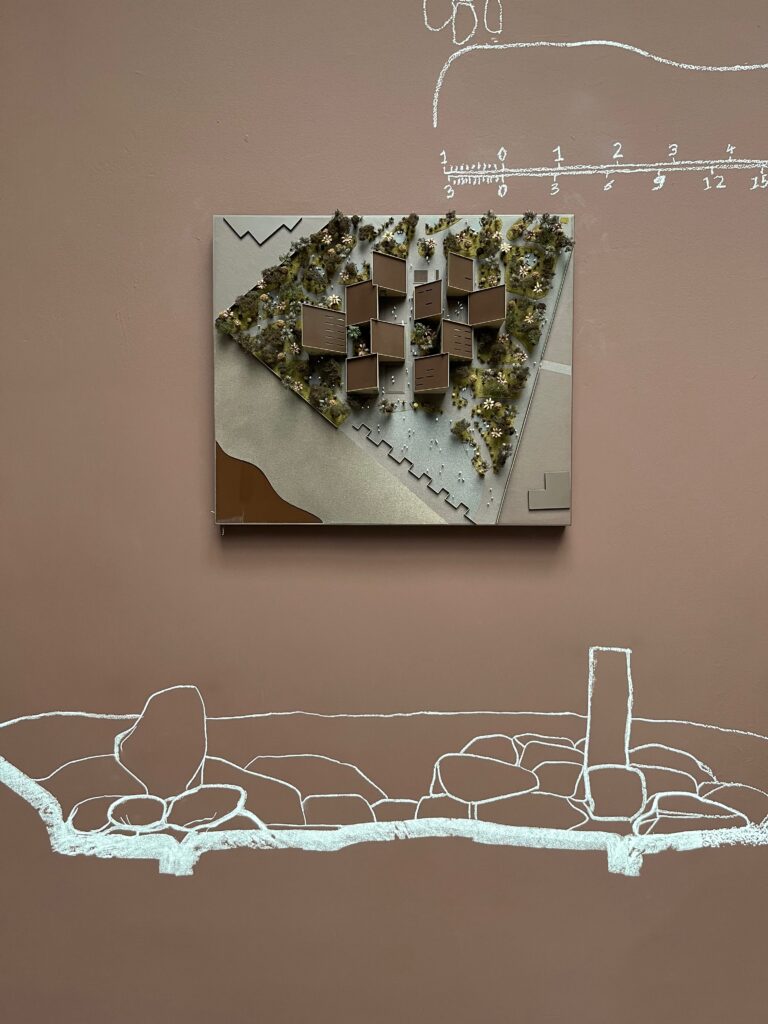
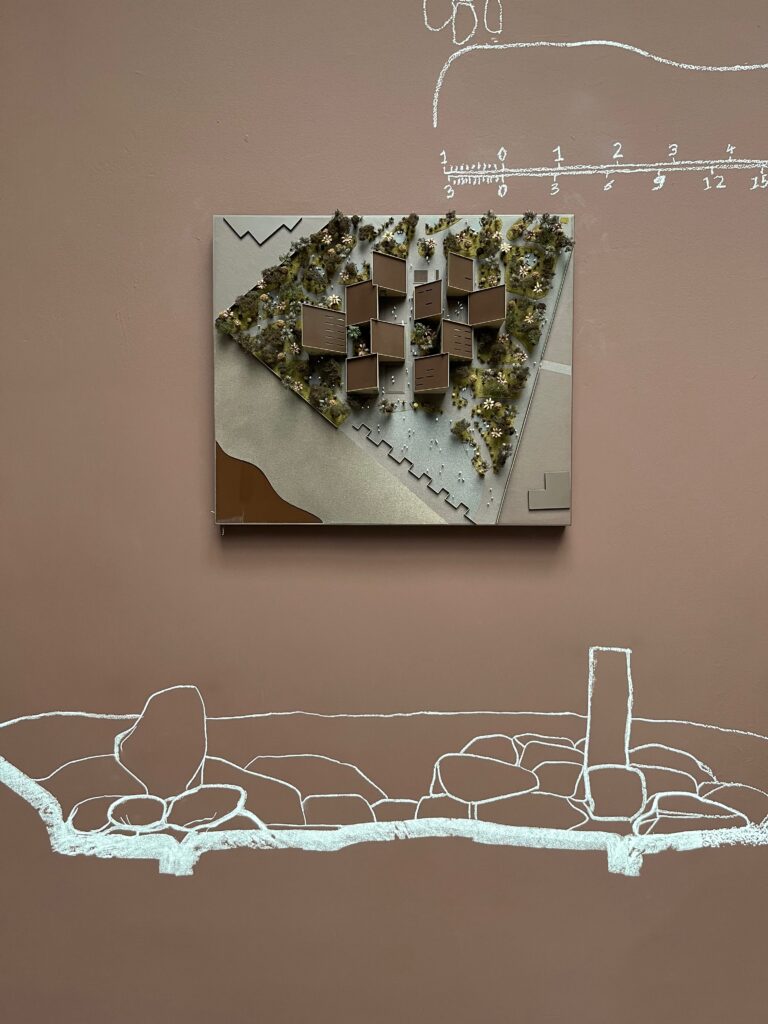


A sinistra, Kéré Architecture, Counteract. Sezione Force Majeure, Padiglione Centrale Giardini. Al centro, Atelier Masomi, Process. Foto di dettaglio di una delle pareti della sala: plastico e disegno. Sezione Force Majeure, Padiglione Centrale Giardini. A destra, Studio Sean Canty, Edgar’s Sheds. Modello a grandezza reale della struttura liberamente ispirata alla baracca del bisnonno nella Carolina del Sud; in primo piano, modello in scala della baracca. Sezione Force Majeure, Padiglione Centrale Giardini
Con lo sguardo rivolto alla tradizione, la struttura
Edgar’s Sheds proposta da Studio Sean Canty è
liberamente ispirata a due baracche costruite dal
bisnonno dell’autore nella Carolina del Sud.
Le semplici forme messe in opera dall’antenato
«nascondevano invenzioni straordinarie» ed
erano portatrici di valori autentici e prassi
virtuose, come il riuso e la cura verso gli altri e
l’ambiente circostante. La funzione della
struttura è semplice e primordiale: offrire spazi
all’aperto dove ripararsi e stare insieme; il tetto
simbolicamente sovradimensionato è il primo atto di protezione, la tettonica è frutto di
un’attenta valutazione dei mezzi a disposizione e
la costruzione è facilmente smontabile per il
riutilizzo. Restando ai Giardini, le partecipazioni nazionali
offrono un palinsesto di chiavi di lettura che
toccano in maniera più o meno centrata le non
certo facili e confortanti questioni proposte dalla
curatela.
Il padiglione della Francia, in preda a una sorta di
isterica euforia, «suggerisce un nuovo approccio
alle crisi odierne, in cui l’enfasi non è più
sull’emergenza, ma sulla possibilità di futuri
alternativi». Le ragioni di tanto ottimismo restano
però inespresse, lasciando spazio a una
programmazione ludico-culturale che per l’intero
arco della manifestazione prevede incontri,
confronti, spettacoli, ambientati in una cornice –
un teatro ricavato all’interno di una gigante
strobosfera sezionata – mondana e frivola ma,
bisogna ammetterlo, esteticamente
accattivante.


Giardini, Padiglione Francia, The Ball Theater. Curatori: Muoto & Georgi Stanishev
L’Austria sposta l’attenzione sulla tematica della
partecipazione per riferire della diatriba in corso
con il comune di Venezia che ha rifiutato di
concedere l’uso di uno spazio pubblico
adiacente ai Giardini per permettere la
realizzazione del progetto – fallito – di collegare
il padiglione al quartiere limitrofo e renderlo
liberamente accessibile a residenti e visitatori
durante la Biennale. Un percorso alternativo –
una scala che scavalca il muro di recinzione
realizzata solo a metà – costituisce il focus della
mostra.
Incentrato invece su buoni rapporti di vicinato è
il padiglione svizzero, il cui progetto illustra la
sintonia con l’adiacente omologo venezuelano e
il legame personale e professionale tra i rispettivi
progettisti. L’assoluta indifferenza al tema
generale si perdona velocemente grazie a un
allestimento riuscito, esplicito e ispirato al
contempo.
Tra le partecipazioni nazionali, tre sembrano
invece aver pienamente accolto l’invito della
curatrice a riflettere e contribuire sul tema della
decarbonizzazione: le mostre realizzate nei
padiglioni di Germania, Spagna e Belgio.
La Germania mette letteralmente in scena il
tema del riciclo dei materiali da costruzione
allestendo il proprio spazio senza
smantellare Relocating a Structure, opera
di Maria Eichhorn realizzata per la Biennale Arte
2022. Componenti di risulta provenienti da
passate manifestazioni si sovrappongono alla
spazialità decisa dall’opera artistica e popolano
lo spazio della mostra Open for Maintenance,
tracciando il percorso dei visitatori e rendendo
manifesta la quantità e qualità di materia
impiegata, e purtroppo troppo spesso non
riciclata, per realizzare manifestazioni di questa
portata. Il padiglione della Spagna è un viaggio di
esplorazione attraverso il sistema di produzione
agro-alimentare del paese, per affrontare
questioni di portata globale. Il racconto
Foodscapes intende mettere in luce lo smisurato
impatto che le catene di produzione del cibo
determinano sui territori. Un tema spesso
dimenticato dal dibattito sulla sostenibilità,
quello delle strette interazioni che intercorrono
tra alimentazione, società e ambiente
antropizzato, viene qui indagato per dimostrare
quanto la produzione, distribuzione e consumo
di cibo condizionino la nostra società e quanto
queste attività incidano sulle metropoli, sui
territori e sulla geografia globale. Il viaggio nei
luoghi deputati a sfamare il mondo si concretizza
in un progetto di allestimento incentrato su 5
cortometraggi e scomposto in una miriade di
disegni e immagini che realizzano un
caleidoscopio di informazioni sul tema,
assediando il visitatore e costringendolo a una
polifagia di notizie, suggestioni, dati.






A sinistra, Giardini, Padiglione Svizzera, “Neighbours”. Curatori: Karin Sander, Philip Ursprung. Al centro, Giardini, Padiglione Germania, Open for Maintenance. Curatori: ARCH+ SUMMACUMFEMMER / BÜRO JULIANE GREB. A destra, Giardini, Padiglione Spagna, Foodscapes. Curatori: Eduardo Castillo-Vinuesa, Manuel Ocaña (foto di Pedro Pegenaute)
Il padiglione belga, infine, con il progetto In
Vivo, propone forse l’intervento più convincente
tra tutte le partecipazioni nazionali. L’urgenza
alla base della proposta è quella di riflettere sulla
limitatezza delle risorse e mettere in discussione
il sistema di produzione, ancora troppo spesso
incentrato su politiche estrattive. In Vivo
propone un’alleanza con il mondo dei funghi, che
possono rappresentare una sorprendente fonte
di materiale, disponibile, sostenibile, rinnovabile.
La possibilità di impiegare il micelio (l’elemento
vegetativo dei funghi) come materiale da
costruzione viene approfondita alle diverse scale
del progetto e testata attraverso un’applicazione
concreta: all’interno del padiglione una
suggestiva stanza nella stanza, completamente
smontabile e riciclabile, mette in opera il
materiale sperimentale come elemento di finitura, realizzando un sistema di facciata
applicato su un telaio modulare in legno.






Giardini, Padiglione Belgio, In Vivo. Curatori: Bento e Vinciane Despret
La Mostra prosegue all’Arsenale con Dangerous
Liaisons (Relazioni Pericolose) e i Progetti
Speciali della Curatrice. Sia nel Padiglione
Centrale che all’Arsenale sono poi presenti le
opere dei Guests from the Future (Ospiti dal
Futuro): giovani “practitioner” africani e
diasporici, così qualificati per espressa scelta
della curatrice.
Il percorso espositivo all’Arsenale è un
susseguirsi di contributi che in alcuni casi
interpretano in maniera commovente il tema
della decolonizzazione.
In Unknown, Unknown: a Space of Memory, uno
spazio fatto di sole luci e suoni celebra una
comunità di schiavi all’University of Virginia
(UVA), Stati Uniti. La modalità espressiva è in
netto contrasto con la tipica volontà di
permanenza del monumento nella sua
concezione occidentale: inconsistenti pannelli in
tessuto fungono da supporto alle proiezioni e
rimandano al lavoro domestico delle donne afrodiscendenti
e agli spazi in cui esse vivevano
all’UVA. Una voce narrante recita dati e
informazioni rintracciate da un gruppo di
ricercatori riguardo le 4.000 persone che hanno
vissuto quell’esperienza di segregazione raziale.
“Unknown” – sconosciuto – scandisce la lettura
come un mantra rivolto a ciascuna di quelle
persone, spesso dimenticate e senza nome, che
l’installazione tenta di salvare dall’oblio.
Nell’allestimento di White Arkitekter, One
Hundred and Fifty Thousand Trees, il tema delle
Relazioni Pericolose viene interpretato alludendo
a una visione spesso riduttiva della natura e del
paesaggio. L’installazione scompone e analizza
un progetto in legno realizzato in Svezia,
esplorandone la tecnologia, le catene di
approvvigionamento del materiale e il loro
impatto sulle foreste, per includere nella
narrazione i luoghi dell’estrazione di legname e
mostrare ciò che spesso rimane invisibile.
Le immagini di un film presentano la realtà della
foresta industriale e l’efficienza della produzione,
accompagnate da voci e da frammenti di discorsi
sull’ecologia, che veicolano le contraddizioni
degli attuali approcci verso le emergenze legate
al clima e alla biodiversità.
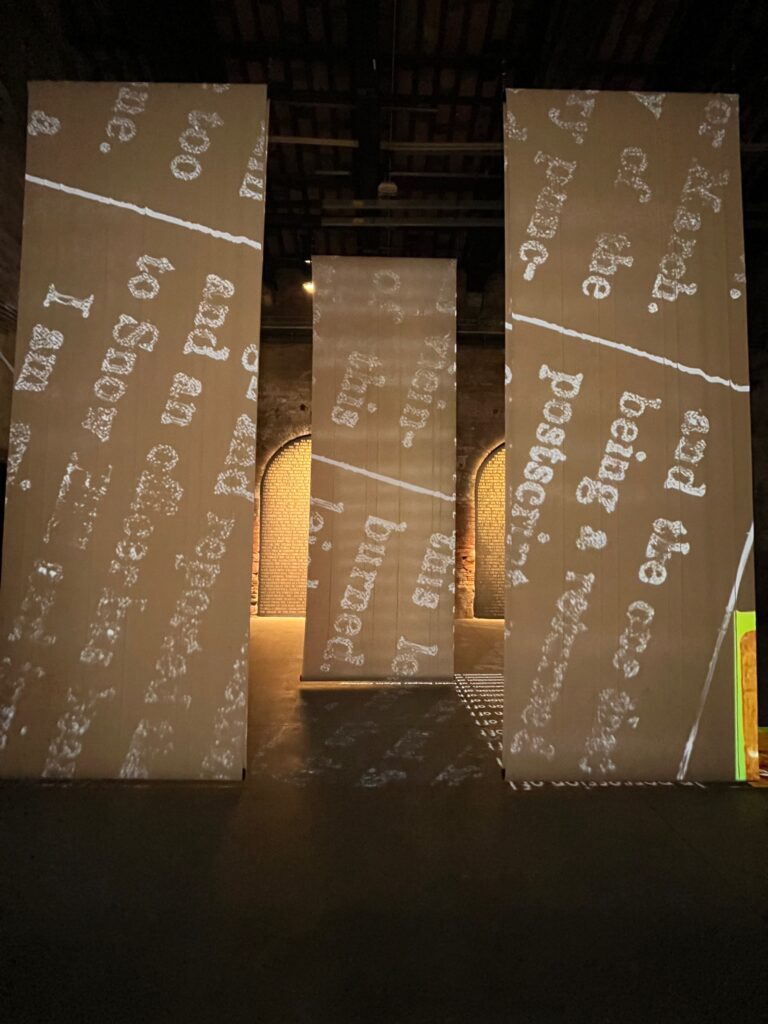
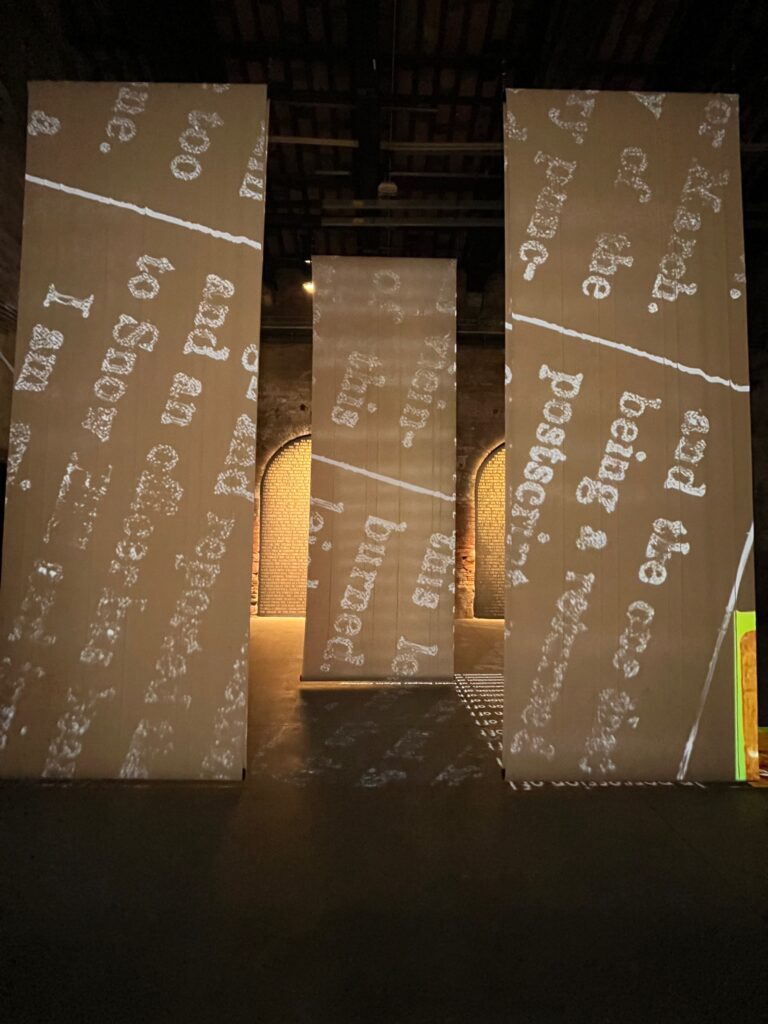


Mabel O. Wilson, J. Meejin Yoon e Eric Höweler in collaborazione con Josh Begley e Gene Han, Unknown, Unknown: A Space of Memory. Sezione Progetti Speciali: Mnemonic. Arsenale




A sinistra, White Arkitekter, One Hundred and Fifty Thousand Trees. Sezione: Dangerous Liaisons. Arsenale. A destra, Estudio A0, Surfacing - The Civilised Agroecological Forests of Amazonia. Sezione: Dangerous Liaisons. Arsenale
Sono numerosissimi i contributi che
meriterebbero di essere ancora menzionati e che
sicuramente sono in grado di offrire ai visitatori
una varietà di spunti e un patrimonio di
conoscenza e di ricerca da indagare e
approfondire. Come sempre, la Biennale di
Venezia è un evento caleidoscopico dove le voci,
le idee, i punti di vista e le suggestioni sono così
numerose che proporne un quadro esaustivo,
un’immagine univoca, un giudizio sintetico, è
impresa faticosa e scomoda.
Certamente alcune reazioni immediate, dopo la
vernice, sono sembrate concordi sull’opinione
che questa sia una Biennale dove si vede “poca
architettura”. La quantità di installazioni
artistiche, manufatti artigianali, video, fotografie,
esiti di esperienze di ricerca o resoconti di attività
temporanee, workshop, eventi sul territorio, è
nettamente preponderante rispetto alle opere
costruite o da costruire ed esposte in quanto tali.
Ma la carestia di risultati concreti e conclusi, a
favore di un’abbondanza di riflessioni, è da
intendersi come sintomatica di un senso di impotenza della disciplina di fronte alle questioni
poste? I mezzi espressivi messi in campo per
discutere di decolonizzazione e
decarbonizzazione sono i soli strumenti
padroneggiati da una generazione di giovani
architetti che pare aver rinunciato a costruire?
L’osservazione sulla “poca architettura”,
condivisibile se si considera che i racconti
realizzati attraverso disegni tecnici e maquette si
contano in tutta la mostra sulle dita di due mani,
insinua ancora una volta la pressante e
onnipresente apprensione rispetto al ruolo
dell’architetto al cospetto delle complesse sfide
della contemporaneità.
Le modalità espressive selezionate dai
partecipanti sembrano però le più consone, o
per lo meno le più calzanti, per intavolare un
discorso costruttivo sulle tematiche proposte
dalla curatrice; non si tratterà allora di un
consapevole passo indietro, per rispondere alle
sollecitazioni avanzate che solo tangenzialmente
hanno a che fare con l’attività del costruire,
piuttosto che di una resa, una rinuncia al fare
architettura?
È la stessa Lokko, del resto, attraverso l’uso della
parola “practitioner”, a rifiutare le qualifiche di
“architetti”, “urbanisti”, “designer”, e identificare
altrimenti le competenze invitate alla mostra.
Eppure il termine, traducibile come
“professionista”, o ancora meglio come “colui
che mette in pratica”, è quanto di più lontano si
possa immaginare da un rifiuto dell’azione.
Come afferma la curatrice: «le condizioni dense
e complesse dell’Africa e di un mondo in rapida
ibridazione richiedono una comprensione
diversa e più ampia del termine “architetto”».
I partecipanti, dal canto loro, sembrano
abbracciare questa comprensione più ampia,
rinunciando a mostrare i risultati più oggettivi e
tangibili della propria attività per partecipare alla
riflessione collegiale cui sono stati chiamati; per
trattare le questioni che interrogano tutti noi, in
prima istanza come individui, e solo poi come
architetti.
Pazienza, dunque, se indugeremo un po’ di più
davanti ai pannelli delle didascalie piuttosto che
ai plastici di stupefacenti edifici.
La Biennale di Architettura stavolta è alle prese
con sollecitazioni esterne: tratta di spreco e
privazione, di egemonie e minoranze, di
costrizione e autodeterminazione, di equità e
divario, di equilibrio e instabilità; tratta di
esperienze e tentativi, perché in un Laboratorio
per il Futuro sarebbe strano trovare risposte già
pronte.
Se il risultato è una mostra che, a prima vista,
sembra una Biennale di Arte, dovremmo essere
disposti a farne tesoro.


Arsenale, Padiglione Cile, Moving Ecologies. Curatori: Gonzalo Carrasco, Beals Lyon Arquitectos
Questo articolo è pubblicato in l’industria delle costruzioni 491 -Infrastrutture per la mobilità- maggio/giugno 2023
Articoli correlati
Una casa “per tutti”. L’architettura democratica di Stefania Filo Speziale tra Capri e Agnano
Dopo Sant’Elia, la riedizione dell’opera originale pubblicata nel 1935
Espansione del MASP, Museo di Arte di San Paulo, Brasile




